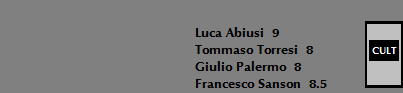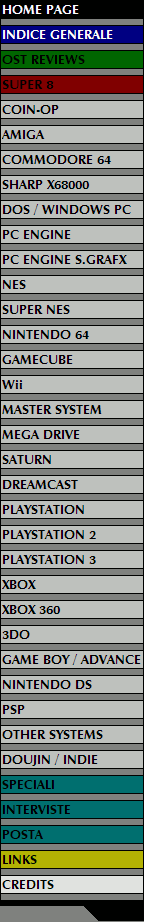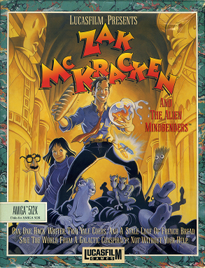 Zak
McKracken è un giornalista del National Inquisitor, testata scandalistica con sede a
San Francisco. Gli verrà chiesto di indagare su questi strani
avvenimenti di fantascienza sul genere di incontri ravvicinati nei
pressi del campeggio di Seattle, e doveva per forza andarci, poiché non vi
era altro modo per dar luogo all’avventura surreale di David Fox e quindi della Lucasfilm
dei dialoghi non possibili, gli enigmi non pensabili. Zak McKracken
diverrà il volteggio degli eccessi delle parole; la mistura sintattica si
impianta al cranio delle gioventù anni Ottanta come il tarlo fa col legno,
poiché di attigua consistenza doveva essere l’intuito del ragazzetto che
ascolta cose come Kenny Loggins. Eppure, e a dispetto dei riflussi e delle
dottrine di un decennio che voleva che la scrittura bruciasse al sacrifizio
della prosa, il titolo parla della evoluzione del videogioco e dei suoi
testi; l’attore si rimette al racconto. Il riporto direzionale, l’appiglio
cui issarsi per almeno ottenere il rendiconto dell’immagine è scartavetrato in
favore della lettura irriverente,
in modo che anche gli estimatori della struttura testuale potessero esserne
piegati.
Zak
McKracken è un giornalista del National Inquisitor, testata scandalistica con sede a
San Francisco. Gli verrà chiesto di indagare su questi strani
avvenimenti di fantascienza sul genere di incontri ravvicinati nei
pressi del campeggio di Seattle, e doveva per forza andarci, poiché non vi
era altro modo per dar luogo all’avventura surreale di David Fox e quindi della Lucasfilm
dei dialoghi non possibili, gli enigmi non pensabili. Zak McKracken
diverrà il volteggio degli eccessi delle parole; la mistura sintattica si
impianta al cranio delle gioventù anni Ottanta come il tarlo fa col legno,
poiché di attigua consistenza doveva essere l’intuito del ragazzetto che
ascolta cose come Kenny Loggins. Eppure, e a dispetto dei riflussi e delle
dottrine di un decennio che voleva che la scrittura bruciasse al sacrifizio
della prosa, il titolo parla della evoluzione del videogioco e dei suoi
testi; l’attore si rimette al racconto. Il riporto direzionale, l’appiglio
cui issarsi per almeno ottenere il rendiconto dell’immagine è scartavetrato in
favore della lettura irriverente,
in modo che anche gli estimatori della struttura testuale potessero esserne
piegati.
Si è in priorità di stare dietro l’indizio,
ma però senza farne un atto di urgenza, ché la condizione di stallo è la
costante da mettere a complemento del castello delle opzioni derivanti lo
SCUMM, presto a schermo, fino a strisciare col mouse e realizzare il senso dello humor e il nonsense alieno
della sequenza di culto, come quando si indossa gli occhiali di Groucho Marx
a elusione degli extraterrestri, o come quando si deve assemblare tute da
astronauta con una muta da sub e una brocca per pesci; dentro il paradosso
di una sceneggiatura di mirabile ostruzione si dovrà grossomodo diventare
gli oggetti spaesati (nonché centrali) della graphic novel di
interazione, che se si vuole è la traccia a spostamento del cursore che la
storia avrebbe poi accostato alla deriva del punta e clicca. La filosofia dell’ispezione
maniacale prenderà il sopravvento sulla volontà, in verità assai latente,
di abbandonarsi a cercare sul web su una qualche soluzione guidata. Non sia
mai. «L’impegno usa
premiare», dice Fox, e la chiave per la prosecuzione potrà (dovrà) essere
raccolta anche sulla via incidentale, dopoché ogni singolo percorso di
risoluzione sia stato battuto e allorché il tentativo di dare un senso al
racconto abbia istruita la facoltà del contrappasso. E comunque, se il
videogioco è d’uso spacciare il garbuglio degli eventi fuori dell’impianto
della logicità, la sua infrastruttura di comandi mirati e semplici, di
azioni eseguibili manovrando d’istinto, crea la trasformazione del gesto
meno gravosa di quanto parrebbe se giusto intrisa delle complicanze
concettuali fornite allegate le avventure della Sierra, che anche erano
graziate dai testi di Roberta Williams.
Fase due: il pennello. Si colora in calco di
pennarelli a evidenziatore per meglio definire il tratto allungato, lo
sfondo di marcatura della prospettiva, e l’animazione essenziale degli
ambienti a otto bit – il titolo è port diretto da Commodore 64 –
non collide l’artefazione e anzi completa le stringature del tratto
fumettista che vuole continuare gli stili e il character design di
Maniac Mansion. La tecnica è brillante. Si agisce di scrolling e schermi
di assoluta accordanza alle sovraimpresse parole perché sia in prominenza
di quanto interessanti possono realizzarsi pure le figure di comparsa, entro
il quartiere della sottile ironia disposto da Ron Gilbert per altruismo,
quand’anche in camera di regia si prefigurasse già dall’intro di dovere
deviare per ragione di continuità sul terreno del divertimento indotto,
della balla spaziale da poter scagliare in contro gli stereotipi
dell’intrattenimento serioso delle pubblicità, dove grazie alle tastiere
bianche e al mouse il genitore si sentisse in obbligo di concessione, poiché
«col computer si può studiare». La portanza (la rilevanza) che un qualcosa
come Zak McKracken può comportare rispetto a una generazione giovanile che
in fondo non chiedeva altro che d’essere svezzata, di evolvere oltre
l’inconsistenza della cultura del consumismo e del conformismo, induce a
credere che il suo apporto formativo il videogioco Lucasfilm dovesse averlo
imbastito, e che probabilmente senza questo gruppo di pionieri, di scrittori
e disegnatori bohémien lo scavalcamento dell’idea comune del giochino
elettronico non si sarebbe affermato, negli anni a seguire. O comunque, non
come si è infine assunto sul luogo dell’arte contemporanea.