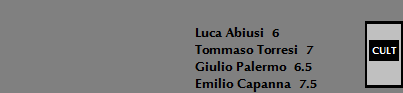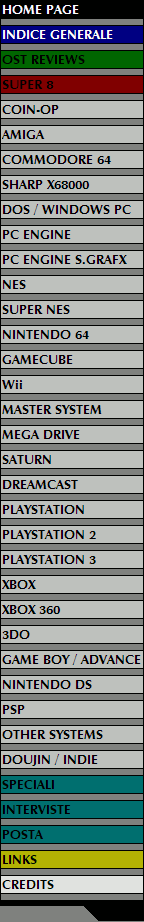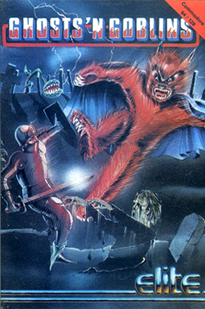 In
quei tempi lontani si beveva ancora il latte, e la genitrice ci inveiva contro
perché si tornava a casa con i pantaloni strappati e le ginocchia peste,
figurarsi dunque se si sapesse cosa fossero Capcom o lo Z80; eppure già allora
si praticava con ardore il culto del salto e dello sparo, dell’annientar mostri,
o del fuggir da essi. L’altare sul quale si metteva in atto codesta fede era il
C64, ed il dio, il feticcio, era Ghosts’n Goblins. Era inevitabile per noi
infanti venir rapiti da tal concentrato di topoi avventurosi/orrorifici: il
cavaliere in armatura che poi resta nudo a combattere era l’alter ego per
eccellenza, e pur privo di lineamenti sul nostro home computer, aveva la
folta barba rossa a infonder carisma; le lapidi, gli alberi spogli, le torri
azzurrine da cui uscivano i demonietti rendevano una tangibile inquietudine
ai nostri giovani occhi, gli zombi, i corvacci, quei maledetti demoni rossi
che ti vengono addosso, gli orchi di ghiaccio e il resto del bestiario
sprizzavano malvagità da tutti i pixel, e poi vi era l’infingarda fiaccola,
forse l’arma più diabolicamente frustrante mai vista in un videogioco: sono
tutti simboli radicati nella memoria, parte del bagaglio culturale di
chiunque si trovasse in età scolare in quei medi ’80 del secolo scorso,
dunque piuttosto che dilungarsi ulteriormente sui singoli dettagli del
titolo in questione preferiremo rimembrare cosa significava giocare allora a
ghosteggobbli,
e provare a dire cosa resta oggi di quell’esperienza.
In
quei tempi lontani si beveva ancora il latte, e la genitrice ci inveiva contro
perché si tornava a casa con i pantaloni strappati e le ginocchia peste,
figurarsi dunque se si sapesse cosa fossero Capcom o lo Z80; eppure già allora
si praticava con ardore il culto del salto e dello sparo, dell’annientar mostri,
o del fuggir da essi. L’altare sul quale si metteva in atto codesta fede era il
C64, ed il dio, il feticcio, era Ghosts’n Goblins. Era inevitabile per noi
infanti venir rapiti da tal concentrato di topoi avventurosi/orrorifici: il
cavaliere in armatura che poi resta nudo a combattere era l’alter ego per
eccellenza, e pur privo di lineamenti sul nostro home computer, aveva la
folta barba rossa a infonder carisma; le lapidi, gli alberi spogli, le torri
azzurrine da cui uscivano i demonietti rendevano una tangibile inquietudine
ai nostri giovani occhi, gli zombi, i corvacci, quei maledetti demoni rossi
che ti vengono addosso, gli orchi di ghiaccio e il resto del bestiario
sprizzavano malvagità da tutti i pixel, e poi vi era l’infingarda fiaccola,
forse l’arma più diabolicamente frustrante mai vista in un videogioco: sono
tutti simboli radicati nella memoria, parte del bagaglio culturale di
chiunque si trovasse in età scolare in quei medi ’80 del secolo scorso,
dunque piuttosto che dilungarsi ulteriormente sui singoli dettagli del
titolo in questione preferiremo rimembrare cosa significava giocare allora a
ghosteggobbli,
e provare a dire cosa resta oggi di quell’esperienza.
Dunque si è detto che il
primo approccio con il classico fu sulla macchina Commodore. Conversione a
cura di Elite, nella persona di Chris Butler. Artigiani con le palle i
nostri, in quegli anni convertivano vagonate di titoli, pesi massimi come
Bomb Jack, 1942, Ikari Warriors,
Buggy Boy,
cercando di rendere il feeling da sala al meglio delle modeste possibilità
dell’hardware a disposizione. Certo, i colori erano pochi e i pixel grossi,
ma visto che non ci era allora permesso, tapini noi, di varcar le soglie di
quelle fucine di criminalità spicciola che erano le sale giochi, non era
ancora il tempo dei confronti con l’arcade; e ad ogni modo quel che qui va
detto, e che i bimbi ciccioni con lo snes oggi come allora con tutta
probabilità stenteranno a comprendere, è che quelle grafiche che potevano
non dire nulla erano per noi tessere di un disegno di cantori e dei che
dicevano tutto, nella squadratura degli sprite a otto bit. Il gameplay
d’altronde era funzionante. L’elevata difficoltà frustrava certo, ma ad ogni
partita si avanzava un po’ di più, le lunghe sessioni pomeridiane furono
dolce irrinunciabile martirio, sudate fredde cariche di tensione, immani
incazzature, grida di felicità al superamento del ponte infuocato, storie di
vita così, come le partite di pallone o il mare. E poi i suoni. Allora non
potevamo sapere che Mark Cooksey aveva reinventato Chopin a bordate di SID
nel mesmerizzante tema portante, in un momento creativo degno di Wendy
Carlos, ma quel pezzo che da funereo diviene incalzante, inframmezzato
dall’agghiacciante grido del Red Arremer, è qualcosa di memorabile anche a
venticinque anni di distanza.
Non molto tempo dopo ci si
trovò finalmente di fronte al cassone, e come si può immaginare fu grande la
sorpresa nell’ammirare i colori e la definizione che umiliavano il nostro
feticcio, nel trovare un diverso ordine dei livelli, una difficoltà ancor
più estrema, ma mitigata dalla presenza di un tasto dedicato al salto, così
che finalmente si poteva saltare davanti a una scala ed evitare la palla di
fuoco in barba alla pianta malvagia, scoprire addirittura un gran finale nel
castello, del tutto assente nella nostra versione domestica, e subir
l’immane tortura di dover rifare tutto una seconda volta per godere del vero
finale. Anche il mood era ben diverso, meno tenebroso, ché quel tripudio di
grafiche e suoni era improntato al divertentismo, con le musichette
parodistiche e i pois sulle mutande di Arthur. Eppure, si notò anche che la
giocabilità era quasi invariata rispetto alla nostra modesta conversione.
Conversione che in fondo al nostro animo si continua ad amare.