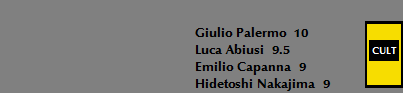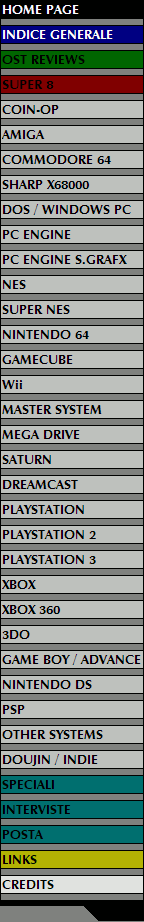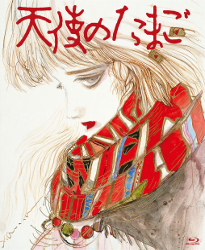 Ci
sono svariati modi per parlare di Angel’s Egg. Potremmo discutere del suo
status di anomalia rispetto all’industria dell’animazione giapponese,
locuzione ormai equiparabile di per sé a una condanna. Fare una disamina del suo
contesto produttivo, con un Mamoru Oshii, non ancora diventato regista di fama
mondiale grazie a Ghost in the Shell, in preda a forti smanie autoriali dopo la
defenestrazione dalla direzione di Urusei Yatsura per via di
Beautiful Dreamer.
Oppure, cercare di tracciare nel film un intreccio o almeno delle tematiche di
fondo, approccio che Oshii stesso accoglie con un’alzata di spalle. No, noi
cominceremmo da Andrej Tarkovskij. La giovinezza cinematografica di Oshii è
stata spesa nelle sale d’essai di Tokyo a guardare la stagione d’oro del cinema
europeo: Godard, Antonioni, Bergman, Fellini, e appunto il regista di Andrej
Rublëv. I punti di contatto tra i due autori sono molteplici, dall’approccio
meditativo alla narrazione, ai tempi cinematografici dilatati, passando per il
lirismo scenico e le tensioni spirituali.
Ci
sono svariati modi per parlare di Angel’s Egg. Potremmo discutere del suo
status di anomalia rispetto all’industria dell’animazione giapponese,
locuzione ormai equiparabile di per sé a una condanna. Fare una disamina del suo
contesto produttivo, con un Mamoru Oshii, non ancora diventato regista di fama
mondiale grazie a Ghost in the Shell, in preda a forti smanie autoriali dopo la
defenestrazione dalla direzione di Urusei Yatsura per via di
Beautiful Dreamer.
Oppure, cercare di tracciare nel film un intreccio o almeno delle tematiche di
fondo, approccio che Oshii stesso accoglie con un’alzata di spalle. No, noi
cominceremmo da Andrej Tarkovskij. La giovinezza cinematografica di Oshii è
stata spesa nelle sale d’essai di Tokyo a guardare la stagione d’oro del cinema
europeo: Godard, Antonioni, Bergman, Fellini, e appunto il regista di Andrej
Rublëv. I punti di contatto tra i due autori sono molteplici, dall’approccio
meditativo alla narrazione, ai tempi cinematografici dilatati, passando per il
lirismo scenico e le tensioni spirituali.
Un film in particolare spicca per vicinanza
ideologica a Angel’s Egg, e ne risulta il predecessore più immediato. Uscito nel
1975 dopo un lungo tira e molla con le autorità sovietiche, Lo specchio è
un’opera ermetica, non lineare e visionaria, che cerca, più che di raccontare,
di raffigurare un luogo dell’animo, il modo in cui nel gorgo del tempo si
diventa ciò che si è. Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine,
direbbe T. S. Eliot; e in segno di continuità con La terra desolata, Angel’s Egg
parte da un mondo spettrale e diroccato, in cui si aggirano un giovane soldato
con un fucile a forma di croce, e una diafana bambina che porta con sé un enorme
uovo, che forse contiene la possibilità di una rinascita, forse invece è vuoto.
Da qui in poi il silenzio, il cuore della luce: Oshii opta per una
linea il meno narrativa possibile, facendo pronunciare ai suoi personaggi
pochissimi dialoghi – in buona parte dei ripetuti “chi sei tu?” – e rendendo gli
accadimenti su schermo non spiegabili se non tramite esegesi. Pretenzioso,
direbbero i maligni: a ogni modo, l’Uovo dell’Angelo ha un guscio arduo da
scalfire, risultando per i suoi 71 minuti una visione criptica, un sogno
guardato dall’esterno.
Il carattere onirico della pellicola è
catalizzato dal fondamentale apporto del co-sceneggiatore e character designer,
uno Yoshitaka Amano in stato di grazia. Per l’occasione l’illustratore dei Final
Fantasy dà fondo al proprio talento, plasmando gli incubi dell’autore di
Jin-Roh: Uomini e lupi
con scenari derelitti, organici, eterei. Tableaux vivants, nella migliore
tradizione cinematografica mitteleuropea. Il respiro di Oshii e Amano soffia
oltre le prove migliori dei loro colleghi di genere, oltre Neo-Tokyo, oltre
Laputa, fin verso la Zona, il pianeta Solaris, e le armonie di Werckmeister.
L’immagine comunica ciò che oltrepassa il regno della parola mozzata.
Le balene, la disperazione, gli uomini vuoti, la catarsi.
Il gorgo in cui si diventa ciò che si è.
Ciò che poteva essere e ciò che è stato
Tendono a un solo fine, che è sempre presente.
L’Uovo è rotto, l’Uovo è integro: il film più sfuggente ed economicamente
sfortunato di Oshii è probabilmente anche quello più pregno di significati,
traguardo non da poco per un regista così spiccatamente politico e filosofico da
risultare problematico per i suoi produttori.
Per quanto ci riguarda, il massimo storico.