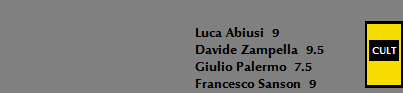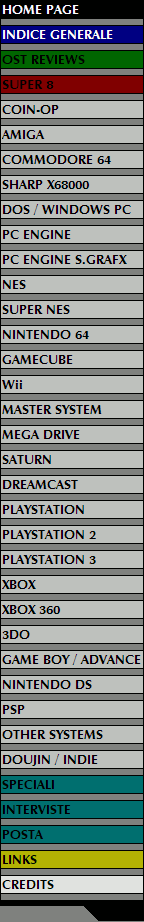Superate
le ventiquattro di un giorno da cani del 1992 poteva essere che Enrico Ghezzi mediasse
tra di Noi e i post-deliri trasfigurazionali nipponici di fine ’80; ricorrendo al
condizionamento mentale, quella notte ci suggeriva di mettere il
videoregistratore in modalità long play, dacché dopo di Akira era
in rassegna previsto Shinya Tsukamoto, per
continuazione di questo cinema sedizioso per nozioni, classi disgregative e
infezioni da rigetto al ferro incubate fuori orario
approssimativamente solo per Noi, che non eravamo
andati al cinema, seppureché Akira, nello stesso ’92, potesse quel che è vero
arrogarsi il privilegio di una distribuzione ufficiale in cinque o sei città
nordiche estratte a sorte. Ma a pensarci fu anche troppo, ché in Italia gli
anime seri, sino a quel momento, dovevi al più guardarteli dietro acquisto
di VHS interdette ai minori sul genere di
Urotsukidōji: La
leggenda del Chojin. Non sapevamo bene chi era
Katsuhiro Ôtomo. Ci
eravamo persi i numeri di Akira in formato manga, al tempo edito da Glénat, se
non che l’impatto col film dovette consumarsi, oraché ce ne ritornano confusi
frammenti, dentro una centrifuga di nozioni
biblico-fantascientifiche riguardanti esperimenti su bambini psichici, oltreché
scorrerie su motocicli forniti di sistemi computerizzati antibloccaggio per i
freni, e per quanto il bombardamento cyberpunk ci avesse
tramortite le viscere fino all’osso non poteva fermarsi adesso,
l’approvvigionamento dell’accelerazione, e delle pastiglie allucinogene sfuse.
Superate
le ventiquattro di un giorno da cani del 1992 poteva essere che Enrico Ghezzi mediasse
tra di Noi e i post-deliri trasfigurazionali nipponici di fine ’80; ricorrendo al
condizionamento mentale, quella notte ci suggeriva di mettere il
videoregistratore in modalità long play, dacché dopo di Akira era
in rassegna previsto Shinya Tsukamoto, per
continuazione di questo cinema sedizioso per nozioni, classi disgregative e
infezioni da rigetto al ferro incubate fuori orario
approssimativamente solo per Noi, che non eravamo
andati al cinema, seppureché Akira, nello stesso ’92, potesse quel che è vero
arrogarsi il privilegio di una distribuzione ufficiale in cinque o sei città
nordiche estratte a sorte. Ma a pensarci fu anche troppo, ché in Italia gli
anime seri, sino a quel momento, dovevi al più guardarteli dietro acquisto
di VHS interdette ai minori sul genere di
Urotsukidōji: La
leggenda del Chojin. Non sapevamo bene chi era
Katsuhiro Ôtomo. Ci
eravamo persi i numeri di Akira in formato manga, al tempo edito da Glénat, se
non che l’impatto col film dovette consumarsi, oraché ce ne ritornano confusi
frammenti, dentro una centrifuga di nozioni
biblico-fantascientifiche riguardanti esperimenti su bambini psichici, oltreché
scorrerie su motocicli forniti di sistemi computerizzati antibloccaggio per i
freni, e per quanto il bombardamento cyberpunk ci avesse
tramortite le viscere fino all’osso non poteva fermarsi adesso,
l’approvvigionamento dell’accelerazione, e delle pastiglie allucinogene sfuse.
Si elegge, Ôtomo, divulgatore di catastrofismi di
notevole annata. Le parapsicologiche approssimature di cui si era reso complice in Harmagedon: La guerra contro
Genma (diretto da Rintaro, voto 4) sono un meccanismo caduto in disuso, e sì
che l’effusione di queste sue nozioni di ante-scienza non compromette
l’apparato visuale, incassate d’anticipo le figure umanoidi del vigente
manga, e se non che Akira si dimostra capace di approfondire sulle diversioni più
oniriche del soggetto, presupponendo che lo spettatore ne venga
coinvolto entro il dilemma del conflitto nucleare inevitabile, che accadrà
dall’interno, niente russie che si armano contro il capitalismo ma giusto
appena la macchina dell’evoluzione del gene che si manifesta sotto
evanescente succedimento del suo marker, autodistruttivo per discendenza,
visione mostruosa, piaga consacrabile all’inglobamento di ciascun sistema
vivente e non vivente aldilà della bolla
di antimateria, nell’istante in cui si venisse richiamati al neutrale stadio
di amebe unicellulari, loro che non hanno timore del “soggetto Akira”, lui
che «verrà per salvarci tutti», nonché per sterminarci tutti. La mano (il
braccio sintetico) del regista inclina multiangolare sullo slipstream
serratissimo delle scie luminose che la moto di Kaneda dissemina a
generatore di persistenza, e si potrebbe venire abbagliati dalle
micro-premonizioni di questo imminente futuro d’irreversibilità
collettivo-spiritualista primaché in termini di traduzione in suono
reminiscente, seppure nessuno al di fuori di Geinoh Yamashirogumi potesse
meglio transumare l’apocalisse delle multipercussioni, ossessione di voci
sovrapposte, frammenti elettronici che dissolvono assieme alle super cavie
sintomo di prenascita, monito per l’umanità.
Più influente che rivoluzionario, che la
rivoluzione dell’animazione giapponese, posto di volersene assumere i
motivi “esterioristici”, dice di avere ottenuto luogo nel 1987 coi
nullaosta di Yoshiaki Kawajiri (La città delle bestie
incantatrici) e Hiroyuki Yamaga (Le ali di Honnêamise,
ma si potrebbe altresì retrocedere all’81 e aprire una disputa sul suo
Daicon
III), Akira è l’ipertrofia di certi ottanteschi flussi di denaro solvente,
stanziabili con tanto di firma d’avallo come strumento di contrasto all’industria
della Disney, sicché non dovessero esservi limiti da
dover aggirare ma piuttosto risorse a cui attingere, e in modo incondizionato, per
la committee di animatori, illustratori, fumettisti, sceneggiatori,
saltimbanchi reclutati da ogni angolo del Giappone al fine di ridefinire il
singolo standard precedentemente notificato alle frontiere dell’anime
perfino nel dipartimento della computer graphics, cui invero si
acconsente in una innotabile attaccatura dimostrativa, datoché il gettito di fotogrammi
surclassanti il miliardo non doveva venire interrotto, durante il passaggio
chiave dell’incubo di Tetsuo Shima, dei giocattoli e i palazzi che si
sgretolano, per quest’uso della luce che vattelo a spiegare, e
che anzi ti sai spiegare nel merito di un ambiente dove se per caso il disegno ultimo non fosse
ritornato uniforme quanto la
superficie di uno specchio di Versailles atterrava Ôtomo, col suo rosso
mantello, a imporne rapidissimo revisionamento, già che sembra il
perfettibile non rientrare nei
termini negoziali stilati a monte, trovandovisi scritto nero su bianco che
Akira doveva essere libero degli errori addebitabili all’umanità malgrado
i tagli sulla sceneggiatura originale, per vero opportuni vistoché il film avrebbe dovuto
sovrintendere a una pellicola di due ore strette. Ma due ore che rimarranno. Non se
ne andranno via le immagini frastornanti e opprimenti di Neo-Tokyo, epicentro
biologico di una nuova stirpe di superuòmini.