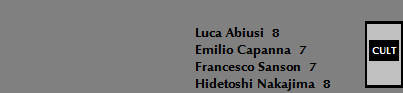Dicasi
manuale che serve a coincidere la statura di una carriera a un’animazione che se
va bene arriva a undici minuti. Si sta parlando di
Rintaro, e di “Labyrinth”. Poiché «mai visto niente così», come rade
voci periferiche vorrebbero in modo lapidario suggerirci di dire, e
verosimilmente a seguito di commessa visione di oniriche dimensioni circensi e
clown maledetti che passano sul televisore per raccontare di racconti di bambine
cui incutere terrore in modalità “Twilight Zone”, sapendo eccome terrorizzare,
la serie TV, e ci rammentiamo in proposito di un episodio dove c’era un bambino
che materializzava i mostri che se lo vedessimo adesso avremmo gli incubi di
nuovo. È che su concessione di una immensa Atsuko Fukushima – si sarebbe
maritata a Koji Morimoto, e ci sentiremmo di non darle torto – il virtuoso
lavoro di cinepresa viene stirato a caratterizzazione felliniana e
sperimentalismi che azzarderemmo d’introdurre in un discorso di fuori campo
cadente sul rosso, stante il necessario ausilio di silouhette di
contrasto verificabili nella rarefazione della non-realtà di Boogeyman, un
incubo di cartapesta abitato da fantasmi e sagome di morte che dicono che era
meglio che non entravi.
Dicasi
manuale che serve a coincidere la statura di una carriera a un’animazione che se
va bene arriva a undici minuti. Si sta parlando di
Rintaro, e di “Labyrinth”. Poiché «mai visto niente così», come rade
voci periferiche vorrebbero in modo lapidario suggerirci di dire, e
verosimilmente a seguito di commessa visione di oniriche dimensioni circensi e
clown maledetti che passano sul televisore per raccontare di racconti di bambine
cui incutere terrore in modalità “Twilight Zone”, sapendo eccome terrorizzare,
la serie TV, e ci rammentiamo in proposito di un episodio dove c’era un bambino
che materializzava i mostri che se lo vedessimo adesso avremmo gli incubi di
nuovo. È che su concessione di una immensa Atsuko Fukushima – si sarebbe
maritata a Koji Morimoto, e ci sentiremmo di non darle torto – il virtuoso
lavoro di cinepresa viene stirato a caratterizzazione felliniana e
sperimentalismi che azzarderemmo d’introdurre in un discorso di fuori campo
cadente sul rosso, stante il necessario ausilio di silouhette di
contrasto verificabili nella rarefazione della non-realtà di Boogeyman, un
incubo di cartapesta abitato da fantasmi e sagome di morte che dicono che era
meglio che non entravi.
Manie-Manie: Meikyû monogatari è volontà di
fusione di classi animate tra di loro in estemporaneo disaccordo, dimodoché
dei tre registi designati si potesse sì eventualmente desumerne la divergenza del
metodo operativo, ma non l’idea icastica da contrare all’anime dei serial televisivi, che erano semplificati in
tutto, che non potevano permettersi di scansire il significato più trasversale
del design de “L’uomo che correva”, un Yoshiaki Kawajiri caduto in trance
telecinetica e proteso allo scaling maniacale delle macchine che vengono
moltiplicate fotogramma dopo fotogramma, duemila rodovetri, ché ancora non si
erano inventate le tecniche di rendering dei mezzi, quelle che verranno
introdotte alla fine degli anni ’90 e che per solamente Takeshi Koike a
tutt’oggi si guarda, e a ragione, dal farne uso; il cortometraggio mette in atto
una super corsa ad anelli concentrici con integrata un’ossessione di
acceleramento che provoca sindromi da schiacciamento di crani, per meglio
ritoccare in eccesso il cinismo di Rollerball – quello vetusto di Norman
Jewisone, 1975, voto 8 – e avviarsi a una conclusione metafisica del pilota
invincibile che surclassa la barriera incorporea del pensiero viaggiando
all’interno di una spirale di futuri quantistici traverso cui misurarsi contro i
sé medesimi digitali in un continuum disgregativo paradossale. Il
microfilm dice assai su quelli che nel giro di qualche anno sarebbero diventati
i fondamenti del cinema di Kawajiri, riconoscendovi in esso il deciso zoom dello
spettro diagonale quanto la neoavanguardia della trasfigurazione antropometrica
delle strutture umanoidi.
Nell’episodio conclusivo – che tecnicamente non
lo è: l’epilogo svelerà il finale di “Labyrinth” – Katsuhiro
Ôtomo cementifica
le basi dello script che avrebbe reso
Roujin Z così sottile e
ironico, nel ’91, per cui si vede il regista ripiegare nella variabile del robot
automa che all’improvviso realizza di dover fare a meno del plusvalore degli
uomini, nonostante che il “campo di contesa” venga qui ridistribuito in un
groviglio forestale che funzionasse da saracinesca tra la civilizzazione e il
luogo impervio, microcosmo non ancora contaminato dall’industria. Sebbene per
poco ancora. Ma la sorridente direzione parodistica, che a modello usa prendersi
l’androide fantozziano che perde i pezzi, non impedisce a quest’Ôtomo
curiosamente ecologista di ammonire circa i pericoli dell’invasività della
manodopera meccanica, che (inevitabilmente) finisce per corrompersi a immagine
dell’uomo; di “Interrompete i lavori” l’autore di Akira è ugualmente
responsabile di soggetto e character design, e diffatti la qualità
grafica del corto, altresì rimarchevole nei dintorni del fondale, rimane
piuttosto alta per l’intera sua durata. Chiude Rintaro, ma non diremo come.
Manie-Manie: I racconti del labirinto avrebbe sicuramente meritato una
distribuzione cinematografica capillare. In compenso, il processo di
riversamento su DVD, risalente al 2006 e anche mancante di una vera e propria
fase di restauro, non presenta artefatti degni di menzione. I colori si
mantegono sufficientemente saturi pure su televisori HD, con un dolby digital
2.0 che rende discreta giustizia alla localizzazione operata da Dynit.